
Lettera di una paziente
Ore 19, mi registrano al pronto soccorso del Policlinico. Inizio della mia avventura. Dopo “i parametri”, mi caricano su una barella e accedo alla sala triage. Oddio quanta gente, quasi non ci credo. Almeno quindici persone in attesa: chi in barella, chi in piedi, chi su una semplice sedia, chi in sedia a rotelle. Inevitabile che, a turno, i pazienti mostrino insofferenza. “Sono buttato qui dalle 7 di stamattina, 12 ore sono passate!”. “Ma almeno mi dite quanto devo attendere ancora?”. “Tra poco vomito qui, non riesco più a trattenermi”. “Alt, stia ferma lì! Sospetto Covid, avanti facciamo il tampone”. “Io non sono autorizzato a fare il tampone, chiama chi deve farlo”.
Passano cinque minuti, arriva un altro infermiere. Tampone eseguito, negativo. “Qua, signora, stia qua”. L’anziana reclina la testa indietro, sul muro, e chiude gli occhi: ha una flebo, la febbre alta, il viso terreo. La figlia dice che vomita da ore.
Chiedo ai miei vicini di barella come funziona, da quanto sono in attesa. “Ho perso il conto, signora. Oltretutto sono sballata. Una povera ottantenne è morta in questa stanza oggi. Il figlio l’ha accompagnata al pronto soccorso ed è andato via, la poveretta dopo qualche ora si è addormentata. Noi vedevamo che respirava, ma poi non respirava più. Abbiamo chiamato l’infermiere: solo così hanno scoperto che era morta. Ma certo, l’avevano messa tra i codici che possono aspettare! Una volta che ci piazzano qui, ci sono turni, ma intanto nessuno viene a vedere come stiamo, né qualcuno ci chiede notizie. Stamu ccà, a bona e’ Dio. Povera donna”. Sospettano che io abbia un infarto, “per fortuna” sono codice rosso. Mi fanno un primo ecg, ed è grazie a Dio negativo. Sono immediatamente retrocessa: ora il sospetto è uno pneumotorace, ma gialla ero e tale sono rimasta. Ce ne sono undici prima di me. Amen.
Ho paura, però, con tutta questa gente malata. “Per favore, può darmi una mascherina?”. Nella fretta di andare non l’ho presa. Me ne portano una “normale”. Cambia il turno. Il nuovo infermiere invece viene a riprendere i parametri e, apprendendo che ho la fibrosi cistica: “Ma che fa con questa mascherina, non serve a niente”. “Purtroppo non ne ho un’altra, nella fretta di andare l’ho dimenticata”. Tutto il personale, peraltro, dagli assistenti socio sanitari ai medici, ne è sprovvisto. Torna e mi porge una FFP2.
Passano le ore. Finalmente ho accesso a una stanza dove mi visiterà un medico. L’infermiere si avvicina, ricominciamo con le domande. Poi si dà da fare per un nuovo ecg: “La cardiolina non funziona, possibile che devo caricare il tracciato a mano?”. In qualche modo riesce ad avere ragione della macchina. Prelievo per gli enzimi. Ok, non ho l’infarto. Il tempo scorre lentamente, trafitta dal pugnale che ho nella spalla. “Si prepari per la radiologia”. Ma io cosa devo preparare? Tutto quello che ho è sulla barella: giubbotto, acqua e telefono. Ma la batteria lentamente mi muore tra le braccia. Resto isolata dal mondo. Fuori i miei tentano inutilmente di comunicare con me e più passano le ore più si preoccupano. Arriva l’ambulanza, mi è concessa una passeggiatina al padiglione E.
“L’rx non è chiara, facciamo una Tac”. Bene, non ho né pleurite, né lo penumotorace. Rincuorata, vado in bagno. Non c’è possibilità di chiudere la porta. L’ausiliare che mi accompagna la apre. C’è un paziente seduto sul water che fuma beatamente. “Ma che sei scemo? Qui non si fuma”. La stanza è stracolma di nebbia chiara: quante sigarette avrà consumato? “Non stavo fumando, stavo cacando, voi vidiri u me culu?”. Torno alla mia “postazione”. “Stroke in arrivo, stroke in arrivo”. Ancora: “Avete sentito? Stroke in arrivo”. L’infermiera si fionda nella stanza dove ci sono anch’io. “Spostate questo letto, la ragazza va nella stanza rossa”. “E cu tu dissi? Iò di cca non mi movu?”. “Ma che ti sembra che stare qui sia un diritto acquisito? Spostatela”. “Ora iò chiamu a me’ marito, che è ai domiciliari, e va vediti cu iddu”. “Senti, puoi chiamare anche il Padreterno, ma da qui te ne vai. Abbiamo bisogno di spazio perché arriva uno stroke, hai capito?”.
La giovane donna viene portata via mentre blatera al telefono, visibilmente alterata. “Stroke arrivato! Stroke arrivato”. Chi corre a destra e chi a sinistra. Quell’esiguo personale di turno si massacra in questo andirivieni: tra flebo, cardioline che non funzionano, dati che vanno immessi al computer, pazienti che vomitano, materiale che non c’è, parenti che vogliono conto e ragione, nervi che saltano, parole grosse che volano. “Stroke arrivato! Stroke arrivato!”. La barella del paziente colpito da ictus sarà sistemata accanto alla mia. Mi si avvicina un infermiere. “Lei stasera resterà qui in osservazione. Dobbiamo capire quale terapia praticare”. Firmo e mi accingo ad andare via. “Stroke arrivato! Stroke arrivato!”. E’ l’una e mezza. E mi è andata molto bene.
Lettera firmata



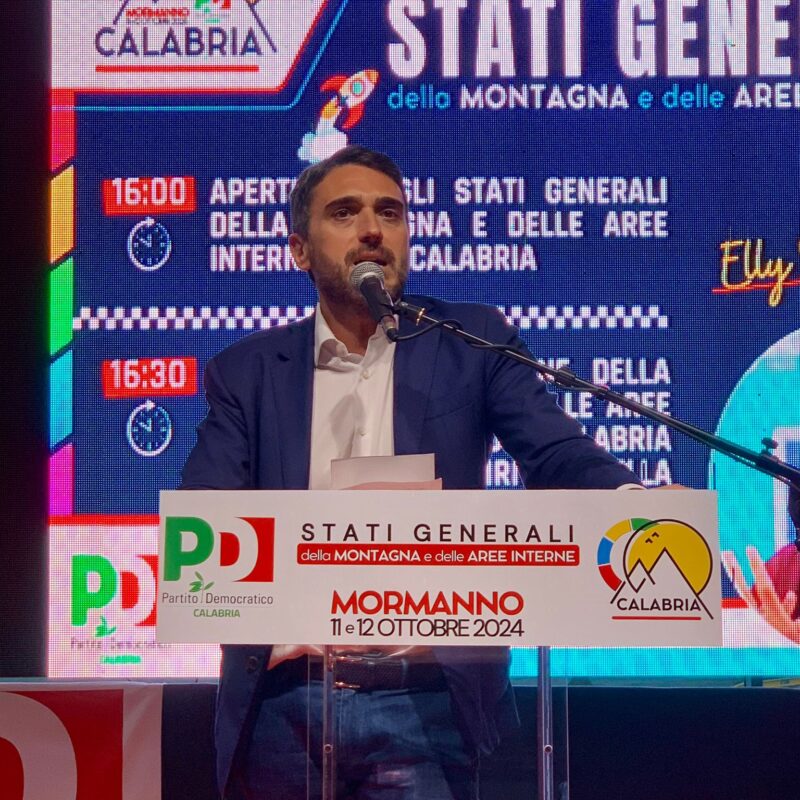


Caricamento commenti
Commenta la notizia