
Uno dei settori maggiormente in crisi nell’epoca del Covid-19 è quello che riunisce cultura e spettacoli. Il distanziamento sociale è la nuova clausola di convivenza che mette totalmente in discussione il modo in cui, nel “prima coronavirus”, abbiamo frequentato sale cinematografiche e teatrali come anche musei e mostre, presentazioni di libri e altre attività. Sarà necessario un ripensamento collettivo lungo una strada in cui neppure il ministero sembra intravvedere il nuovo modo di camminare. Ne abbiamo parlato con l’economista della cultura Michele Trimarchi, messinese residente a Roma, che insegna Cultural Economics nell’Università di Bologna ed Economia Pubblica in quella di Catanzaro.
La cultura italiana è anziana e soffre di patologie pregresse. Potrà superare la crisi da Covid-19? Qual è la possibile cura?
«Da troppo tempo la cultura italiana si ostina a replicare protocolli obsoleti. La crisi sta drammatizzando patologie già diffuse e acute. Lo spirito del tempo soffia altrove, e sbaglia chi ritiene che la società contemporanea sia barbara e ignorante. Al contrario, il montare del desiderio creativo e artistico da costruire e condividere, che la clausura di queste settimane sta mostrando, è la prova che chiediamo risposte eloquenti a una temperie nuova, forse per alcuni imprevista, ma per tutti irreversibile. La cura deve partire dal superamento della ritualità e dell’isolamento, passando per una presenza più diffusa nel tessuto urbano e sociale, approdando al ridisegno dei prodotti culturali, non più icone sacre ma elementi di dialogo. Si tratta di guardare avanti, dunque, liberandoci una volta per tutte dalle zavorre dogmatiche».
Come pensa che i teatri (soprattutto quelli piccoli, dove spesso le idee sono più vive) possano sopravvivere al taglio dei posti?
«Se guardiamo al sistema teatrale degli ultimi decenni ci rendiamo conto che, salvo qualche eccezione felice, la gran parte dei teatri si è nascosta dietro le etichette istituzionali comportandosi da burocrazia assistita. Altro che impresa culturale! Con una compiaciuta inclinazione verso la sindrome di Stoccolma, che il legislatore ha perfezionato con una sequenza di leggine parziali e claudicanti che creavano falle da coprire con la legge successiva, e i professionisti hanno coccolato chiedendo a gran voce una “legge di sistema” (una cosa ancor più costrittiva) e nel frattempo indulgendo in negoziati opachi. I teatri dovrebbero ripensare se stessi come infrastrutture ospitali e multidimensionali, cosa che paradossalmente è più agevole per i teatri piccoli dove si possono sperimentare nuove forme creative. Lo spettacolo si basa su un testo che può essere raccontato e condiviso in tanti modi diversi, in questo caso la dimensione digitale può rafforzare lo svolgersi drammaturgico delle messe in scena, suggerendo possibilità di ottimizzazione delle risorse e dei costi».
Come possono ritrovare un loro avvenire tutti i mestieri necessari dietro le quinte della prosa e della musica?
«Lo spettacolo dal vivo è uno snodo intenso di professioni che combinano una filosofia artigianale e una cassetta degli attrezzi ipertecnologica. È tempo di sperimentare nuovi glossari espressivi, partendo dal basso: assistere a un concerto mentre lo spartito (magari il manoscritto del compositore) scorre alle spalle del musicista darebbe un valore fortissimo allo spettacolo senza minacciarne la pertinenza, anzi tirandolo fuori dalla ritualità parruccona in cui spesso si rimane senza motivo».
Il cinema per sua stessa natura può essere visto anche fuori dalle sale, ma anch’esso in questo caso cambia aspetto. Ci sarà un nuovo modo, più da serie tv, per andare avanti oppure l’economia del settore può ricostruire il rapporto con le sale?
«Anche il cinema ha attraversato stagioni semantiche diverse. Lo abbiamo lasciato con un protocollo piuttosto a buon mercato che ha messo la tecnologia al servizio di lunghissimi preamboli pubblicitari, dilatando anche la dimensione del bicchierone di carta dei pop-corn. Si può fare molto di più. “Avengers: endgame” è durato ben più del normale, la struttura narrativa delle serie ha finito per farci considerare due ore insufficienti per tribolare su una storia. Anche qui è questione di format, sperimentare è un percorso lungo e incerto, ma non possiamo più farne a meno. Disporre di diversi canali di scambio non depotenzia necessariamente le sale, ma richiede un loro ripensamento strategico che coinvolga l’intera filiera creativa e produttiva. Vale per il cinema così come per i musei e i teatri: offrire un’esplorazione estesa che metta a fuoco le azioni a monte (uno scavo archeologico) e a valle (un restauro) darà ancor più valore all’esperienza culturale. E permetterà di evitare l’ammuffirsi progressivo di opere, manufatti, strumenti e memorie nei sotterranei».
Anche i musei si “riciclano” nell’online, mentre le grandi mostre sono diventate sepolcri di se stesse: quale può essere la reazione vincente?
«I musei farebbero bene ad approfittare di questo limbo per ristrutturare i propri spazi. Tuttora la filosofia di fondo dei musei è una sorta di white cube, per quanto decorato, in cui una sequenza di opere poste in ordine cronologico o tematico aspetta che il visitatore svenga o quanto meno si emozioni. Zero dialogo, offerta scolpita nel bronzo, domanda snobbata e al massimo indottrinata con nozioni scolastiche. La scommessa risiede nella costruzione di percorsi che vogliano ragionare insieme a visitatori che – è tempo di prenderne atto – sono eterogenei, curiosi e versatili. In questo quadro i musei devono ripensare sé stessi come snodi narrativi dell’intero territorio, e possibilmente atteggiarsi in modo tentacolare, “invadendo” gli spazi urbani. A Messina quanti manufatti (fregi in pietra, stemmi nobiliari, balconi, colonne) giacciono nei depositi in seguito al terremoto del 1908? Si può pensare a “restituirli” alla comunità? Certo, con tutte le cautele. Ma così sarebbe il museo a collocarsi dappertutto, e molte persone sarebbero indotte a visitarlo per averne ammirato pezzi storici nei luoghi che frequentano tutti i giorni».
Un’ultima domanda: cosa consiglia per far vincere al pubblico la paura di stare in gruppo, che ognuno di noi inevitabilmente porterà a passeggio con sé dopo questa quarantena?
«Le regole della cautela sono piuttosto chiare, magari ci si potrà abbracciare di meno ma condividere l’esperienza culturale non richiede ammassi umani, salvo che non si cada nelle trappole blockbuster come le mostre degli impressionisti (che peraltro non fanno per niente bene né alla cultura né alla società). Sperimenteremo percorsi più sereni e meno affollati, magari assistendo agli spettacoli da salottini dislocati in platea invece che da poltrone messe in fila. Se rinunciassimo all’intensità dell’esperienza culturale finiremmo per avere più paura».





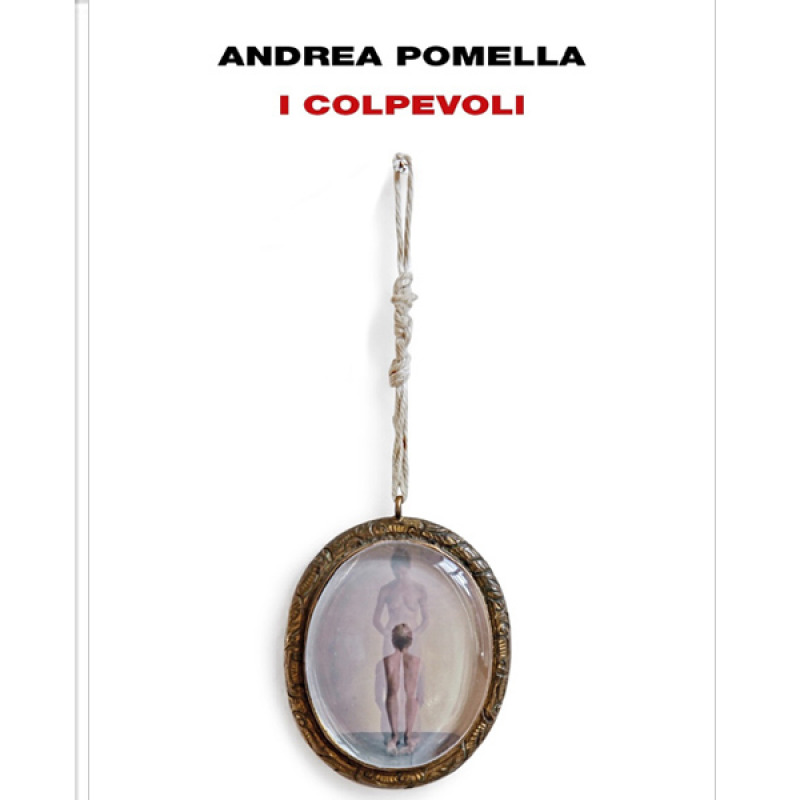


Caricamento commenti